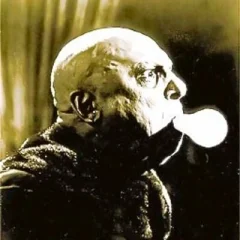Perché sarebbe peccato desiderare la donna d’altri?
Ciò m’è parso subito ingiusto… fin dalla prima volta che ne ho sentito parlare. Sarebbe lunga la genesi della mia opinione in merito, da spiegare. Bisognerebbe parlare di casi specifici e linee di principio, di epoche e costumi diversi, di emancipazione e di ciò che è oggettivo e ciò che non lo è, passando in rassegna gusti e preferenze.
È possibile che lo farò comunque. Anzi, è probabile che mi dilunghi e che, qualche sciocchezza, alla fine, la dica, ma mi permetto di mettere un poco le mani avanti perché, anche se l’evolversi delle mie idee le ha mutate più volte di forma e contenuto, negli ultimi decenni, spero nessuno, specialmente i più ortodossi, mi condannerà per esse. In fondo, simpatizzante e fan di molte faccende divine, io non permetto quasi mai al mio sarcasmo di degenerare in supponenza, almeno dopo i pasti, quando l’umore è migliore, e di scadere in impietosi paragoni tra i tempi dell’Esodo e oggi e in semplificazioni spicciole, se non per gioco, per far due chiacchiere tra amici.
Non è infatti detto che norme di condotta di tremila anni fa fossero senz’altro errate, solo perché oggi le riteniamo desuete. Mi vengono in mente diversi esempi di regole che oggi non valgono quasi più per nessuno oltre a me – come cedere il passo a qualcuno, per strada, non svuotare completamente un piatto o spegnere la luce lasciando una stanza anche se devo tornarci – cui mi rifaccio volentieri, senza che nessuno me l’imponga, come farebbe un forzato che ha avuto il tempo di abituarsi a portare una catena, che si sente a disagio quando lo liberano.
Ciò non toglie che “non desiderare la donna d’altri” mi parve sempre un messaggio sibillino, che non aveva molto in comune con la regola civile, tuttora abbastanza utile, di astenersi dall’importunare le signore impegnate e condanna qualcosa di involontario, quindi impossibile da vietare, come non si vieta il respiro o il battito del cuore.
Ok, Matteo sostenne che anche Gesù suggeriva che ci si strappasse un occhio, se aveva peccato, per evitare ch’esso trascinasse tutto il resto nella geenna. Eppure, mi parrebbe un’altra regola buona a titolo esplicativo, per capirsi, ma da non prendersi troppo alla lettera.
Se potessi fare una domanda a Mosè, per esempio, prima di ogni altra cosa, gli chiederei: come si può giudicare un pensiero cattivo se l’azione è buona? Posso essere ritenuto colpevole se, sottoposto a pressione, tuttavia resisto, grazie alla volontà, alla coerenza o perché l’unica felicità che desidero richiede di non contrariare mai la mia volontà e la mia coerenza?
Sì può condannare chi, tentato, non cede alla tentazione? …Ed è sempre santo chi tentazioni non ne ha, oppure ha solo poca fantasia?
Se mi trovo di fronte a un bivio, posso esitare anche a lungo sul fatto di svoltare a destra, ma, se scelgo di andare a sinistra, perché mi si dovrebbe rinfacciare di aver “desiderato” di andare a destra?
Sbaglierò senz’altro ma, parafrasando Tolstoj, non dovrebbe mai spettare agli uomini di giudicare le colpe di altri uomini. Tutt’al più, essi potrebbero temporaneamente trovarsi d’accordo su quali siano i comportamenti da incoraggiarsi o no in un certo ambiente. Chi mai potrebbe essere così arrogante da credere che possa esistere una regola per sempre giusta?
Inutile negare, caro Mosè, che comporre regole incomprensibili, senza didascalie o decreti attuativi, le rende suscettibili di interpretazioni arbitrarie e sottopone il popolo alla concreta possibilità di ingiustizia.
Vero è che il dubbio educa a scendere a compromessi con il proprio senso di giustizia, che da un lato è positivo, perché smussa gli spigoli alla nostra presunzione, facendo di noi individui meno spocchiosi e più amabili ma, dall’altro, svilisce il nostro sapere, pur esiguo. Del resto, a pensare di sapere si pecca di superbia, che un’altra brutta cosa. Fortunati allora sono quelli che davvero non sanno nulla.
Perché il semplice desiderio di uccidere… o rubare… non sarebbero peccato? Perché dire solo “non rubare”, mentre per la donna d’altri è sufficiente il pensiero? Che sia stato un errore del traduttore? Il dubbio viene: la lingua si evolve e “non commettere adulterio” e “non fornicare”, che erano forse un po’ brutali a scuola di dottrina, ma di certo più evocative, diventarono “non desiderare”, che oggi sembra un comandamento ad uso delle fidanzatine gelose… “Ti ho visto che guardavi il sedere della vicina di ombrellone! Dio ti punirà!”
Sì, c’è quell’altro comandamento, “non desiderare la roba d’altri”, ma è probabile, altrimenti sarebbe un doppione, che si tratti di un’esortazione subliminale a un approccio epicureo alla vita… prima che ci pensasse lo stesso Epicuro e prima che qualcuno ritenesse di condannarlo all’eterna dannazione tra i peggiori miscredenti senz’anima dell’antichità… comunque, un invito a essere contenti della propria, di roba.
Sulle donne, invece, c’è solo quello. È possibile che, poiché il comandamento sulla roba arriva subito dopo, si pretendesse di considerare una donna come roba propria, che a quei tempi non doveva suonare lesivo della dignità femminile come ora, forse.
Ok, vorrei spezzare una lancia a favore di Mosè, perché non dev’essere stato semplice scolpire nella pietra i comandamenti. Essere sintetici fu forse necessario, nel deserto, a mani nude. Già in un paio di altre situazioni Mosè aveva mostrato il suo carattere irruente, del resto. Probabilmente bisognerebbe solo dare per assunto che Mosè fosse, in quel frangente, pressato dalla fretta e sforzarci di immaginare un’interpretazione, per le sue leggi, estensiva, adatta alle circostanze di allora ma anche agli uomini di oggi, molto diversi, per concezione e modo di pensare, da come viene descritto il suo popolo.
Si ricorderà che, mentre Mosè lavorava, i destinatari delle sue leggi fondevano oro per costruire un idolo da venerare; quindi, chi sono io per giudicare l’idoneità di un messaggio rivolto ad altri? Evidentemente Mosè conosceva i suoi polli. Allora forse quelle parole parvero più azzeccate di ciò che sembra ora…
Se Mosè avesse scritto, che so, “mantieni la parola data”, che sarebbe forse il miglior comandamento dei dieci, se ci fosse, se non altro perché in paradiso si starebbe più comodi, in due o tre… allora potrei capire. La fedeltà è infatti una promessa mantenuta; ha a che fare con la coerenza, con la virtù e con la verità.
Invece, il desiderare la donna degli altri comincia prima, insieme a quello per la donna di nessuno; ha a che fare con quello che vedi, che non puoi fare a meno di vedere, con quello che senti, che non puoi fare a meno di sentire e, naturalmente, con quello che sai, dato che non tutte le donne che desideri si tatuano in fronte il nome del marito… Ha a che fare, soprattutto, con ciò che scegli come giusto, dopo aver visto e sentito… e saputo.
Per molti individui dev’essere una sofferenza spesso inutile fingere di non vedere, come se chi ama le lasagne dovesse resistere alla fame, trattenendosi dall’assaggiare la carbonara, per fedeltà alle lasagne. Tutti amano le lasagne, che significa? La fedeltà è una scelta successiva, come il veganismo e la squadra del cuore. Non ha nulla a che fare con gli istinti, con le regole dell’attrazione.
Penso che dovremmo parlarne. Dovremmo proprio trovarci a una tal data e, come Mosè coi suoi seguaci, come Gesù coi farisei, stabilire se certe regole, anche se sonoramente desuete, rumorosamente sessiste, antidemocratiche e contrarie alle ormai più accettate leggi biologiche e antropologiche, debbano perdurare o, finalmente, essere sostituite.
Io, per esempio, proporrei umilmente di inserire “desidera ciò che vuoi, ma sii coerente con ciò che scegli”, da abbinare al sempre utile “non tradire mai la fiducia di chi te ne dà”. Certo, m’inchino a proposte migliori. Sono sicuro che non mancherebbero profeti, anche in erba, più creativi di me… È del resto noto che immedesimarsi coi santi e i discepoli sia raro; il destino di sofferenza e di sacrificio non è ambito, mentre a tutti capita di aspirare, prendendo a modello gli dèi conosciuti della mitologia greca e latina, con le loro opulente vite immortali, alla divinità.
L’uomo, eternamente precario, anzi precariamente precario, ama e ringrazia per ciò che ha, perché è saggio e capisce che potrebbe perderlo, ma desidera necessariamente ciò che gli manca. È nella sua natura e gli è impossibile non farlo, salvo poi resistere, non essendo in completa balìa dei sensi, e vivere in coerenza con i suoi principi e le sue scelte. Egli non ha che la sua parola e il tempo disponibile per onorarla o rimangiarsela; il resto non esiste e, se esiste, non conta, e se conta, è tutta colpa di Mosè.